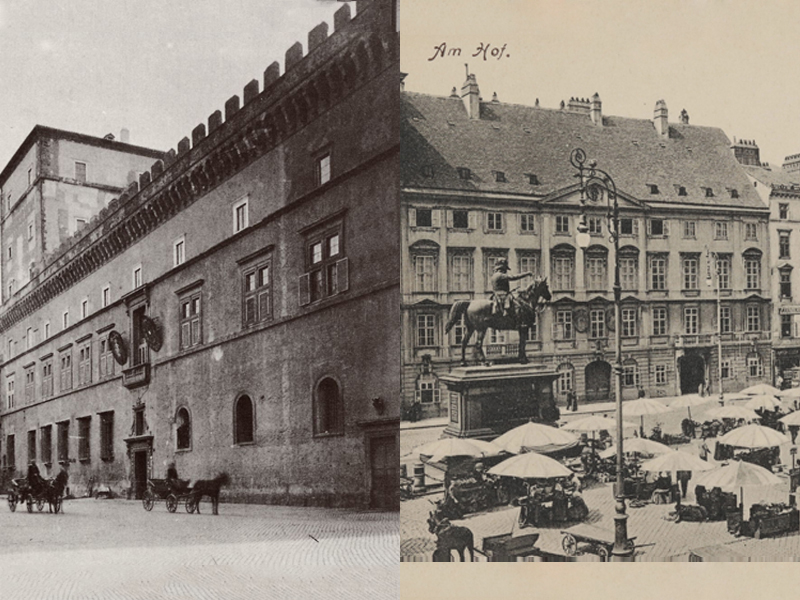
Il presente libro ha lo scopo di colmare le lacune storiografiche nella storia delle relazioni tra lo Stato imperiale e il Papato, specialmente per quanto riguarda gli sconvolgimenti della metà del secolo. L'alleanza tra trono e altare è stata una delle basi politiche della monarchia asburgica fin dalla Controriforma, eppure le relazioni tra Vienna e il Papato sono state analizzate dalla ricerca solo parzialmente. Fondamentali per il XIX secolo sono gli studi di Alan J. Reinerman (Austria and the Papacy in the Age of Metternich 1809-1838) per la prima metà del secolo e di Friedrich Engel-Janosi (Austria and the Vatican 1846-1918) per la seconda metà del secolo. Entrambe le opere si basano sui rapporti degli ambasciatori asburgici a Roma, mentre le fonti vaticane furono consultate da Reinerman solo fino al 1838; Engel-Janosi non poté consultarle. Inoltre, molte aree tematiche vengono analizzate solo en passant. In particolare, manca completamente un'analisi del regno di Ferdinando I, sebbene si tratti di un periodo caratterizzato da forti tensioni: lo Stato Pontificio rifiutava, infatti, di accettare le riforme richieste da Metternich, ma dipendeva dall'appoggio della monarchia asburgica per reprimere i disordini sociali e politici. Allo stesso tempo, Roma esigeva da Vienna un allontanamento più radicale dal sistema giuseppino basato sul concetto di Chiesa statale.
Nell’ambito di questa analisi basata sulle fonti ci si sofferma in particolare sul ruolo degli attori diplomatici: Rudolf von Lützow rappresentò la Monarchia Asburgica presso la Santa Sede dal 1826 al 1847. Lui e i suoi successori – tra cui Alexander von Bach (1859-1865) e Alexander von Hübner (1865-1867) – furono tra i diplomatici asburgici più importanti del loro tempo. Tra i nunzi papali a Vienna vi erano anche personalità di spicco, come Ludovico Altieri (1836-1845) e Michele Viale-Prelà (1845-1856), sui cui rapporti esistono ad oggi pochi studi. I diplomatici godevano di una libertà d'azione relativamente ampia da entrambe le parti e, quindi, finirono per plasmare le relazioni bilaterali.
Le questioni politiche erano molto ampie: dopo la breve era di riforme sotto il Segretario di Stato Consalvi e l'elezione del “fondamentalista religioso” Annibale della Genga a papa Leone XII, i cardinali della Curia che circondavano il Papa – i cosiddetti "Zelanti" – puntarono a ripristinare i principi religiosi premoderni; l'opposizione interna fu duramente soppressa. La debolezza del Papato in politica estera e il declino dello Stato Pontificio erano in netto contrasto con l'auspicato rafforzamento del potere papale e la pretesa del Papato di ottenere la supremazia morale nel mondo cristiano occidentale. A causa del suo duplice ruolo di capo della Chiesa e di capo dello Stato, il Papa si trovava in una situazione conflittuale, diviso tra le rivendicazioni teologiche e la realtà politica. La monarchia asburgica fu fortemente coinvolta in questi sviluppi, non da ultimo per la sua funzione di potenza regolatrice in Italia, ruolo che esercitò a partire dal Congresso di Vienna. Come capo del secondo Stato italiano più grande, il Papa era un partner geopolitico indispensabile. La Chiesa, inoltre, rappresentava il pilastro morale-ideologico centrale delle politiche antiliberali e antirivoluzionarie di Metternich. Sul piano interno, il governo imperiale accolse le proposte papali, riorganizzando il rapporto Stato-Chiesa nel Concordato del 1855, ma la resistenza dei liberali portò la monarchia asburgica sull'orlo di uno scontro tra civiltà: Furono soprattutto le leggi confessionali (1868) e la revoca del Concordato (1870) a pesare sulle relazioni bilaterali.
Questo è il lasso temporale su cui si concentra il progetto, partendo dall'ascesa al potere di Ferdinando I fino alla fine dello Stato Pontificio. In particolare, la ricerca si incentra sul decennio prima del 1848, un periodo che è stato ampiamente trascurato dagli studi, così come sugli effetti che il cambio di paradigma, che si manifestò nell'anno degli sconvolgimenti, ebbe sui rapporti tra Imperatore e Papato.
